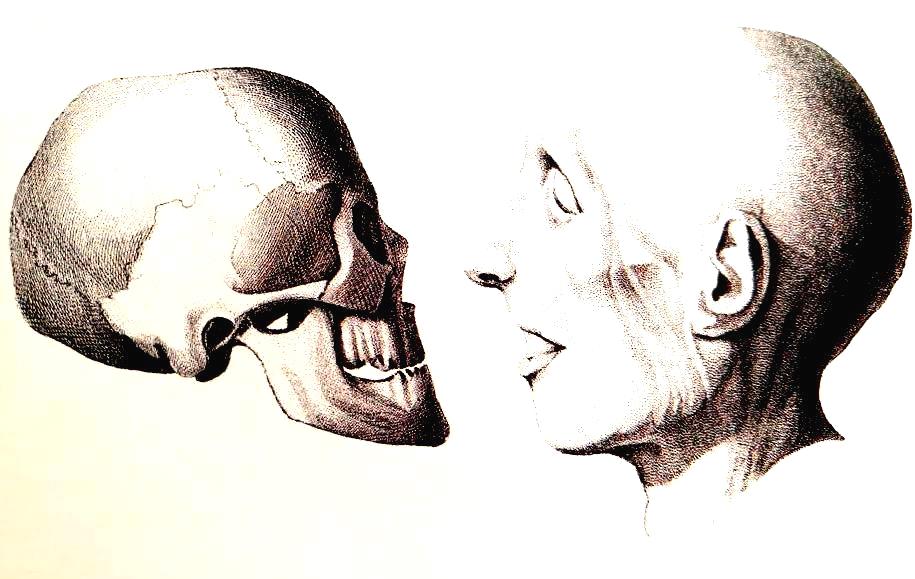Mi chiamo Guignol e sono più di tre secoli che ho una faccia di culo. Dicono che questo sorriso da ebete sia nato nel Settecento per colpa di un certo Laurent Mourget, io personalmente mi sono visto nascere in Cina ai tempi di Ai Weiwei. Il sorriso da ebete è l’unica espressione che mi hanno concesso, ma comunque è più onesto del selfie che hai appena postato. Io sembro un kouros che in effetti non gliene ne sbatte niente di niente, tu che ridi si vede che hai pianto.
Non fatemi pensare a quante volte mi hanno asfissiato e ammaccato dentro gli imballaggi e sotto gli altri scatoloni, prima arrivare in quel negozietto di souvenir scadentissimi a Croix-Rousse. La cosa importante è che, alla fine di quella via della seta infinita, fossi tornato a Lione. Puzzo ancora di plastica tossica made in China, ma ora che mi hanno comprato, non ho più l’etichetta. I miei compagni di legno erano più presentabili, ma io costavo poco.
E così, da quel 13 gennaio 2017, che faceva un freddo maiale, l’operaio che ero ha di nuovo una padrona. Di lei, inizialmente, ho conosciuto solo la mano che mi ha arraffato. Esattamente la destra: più gelida di Winnipeg in inverno, più morta del marmo, più screpolata della carta abrasiva. Chissà perché sempre più gelida, morta e screpolata della sinistra. E si vedeva chiaramente che aveva sanguinato in due punti, sul dorso, a sud-est e a sud-ovest dell’indice. Se vi aspettate che ora mi fissi ipnoticamente su tutto l’iter rossastro della fuoriuscita di piastrine, grattugiatevi le nocche su un muro e poi fatemi sapere. L’unica cosa che conta è che, quando la mia padrona mi ha arraffato, sulla sua mano destra c’erano due crosticine stagnate. E che schifo.
Comunque lei si chiama Livia, è discretamente figa e non so come sia possibile, visto che abbiamo le stesse sopracciglia. Quando si mette il fondotinta il copriocchiaie la cipria il fard il kajal la matita il rossetto rosso, finisce che sembro suo padre. Cioè dire, ultimamente sembro sempre suo padre.
Per colpa di Livia ho interrotto il mio stato di quiete, mi sono staccato dallo scaffale squallidissimo in cui ho abitato come un’ostrica per quattro anni e ho iniziato a cambiare cielo a cadenza regolare di massimo tre rotazioni della terra attorno al proprio asse. Questa cosa molto semplice – che sarebbe “ogni tre giorni” – voglio dirla in modo molto complicato, perché c’è gente che si è conquistata l’immortalità annichilendo altra gente con perifrasi astronomiche lunghe tre endecasillabi. E fondamentalmente io non voglio morire, anche se sono fatto di plastica tossica.
Ultimamente Livia s’è fissata con una canzoncina e non c’è verso di farle togliere il comando “ripeti” da tutti i dispositivi di riproduzione di file audio a sua disposizione. Se nella morte polvere torniamo, tutti i cinesi saranno zafferano, polvere d’orzo quelli di colore e cocaina chi tirando muore. Devo ammettere che il ritornello è simpatico, ma capite benissimo che questo loop mi manda un tantino in paranoia. La storia parla chiaro: io non sono uno di quei burattini che se fanno i bravi diventano umani in carne e ossa, non ho mai acquisito il diritto di cittadinanza nella Bibbia e non avrò nemmeno la soddisfazione di vedermi sfuggire la carne dalle ossa. Comunque, quanto a morire, state certi che dovrò farlo anch’io.
Livia ha deciso che quel giorno arriverà presto, glielo leggo negli occhi. Da quando che ce ne siamo andati da Lione, cambiamo cielo continuamente. A dire il vero, lei cambia cielo continuamente da quando ha raggiunto la maggiore età. Sulla prima pagina della sua agenda ha trascritto una frase in latino. Prende un po’ di mira quelli che fuggono di là dal mare, dice che cambiano cielo, ma non stato d’animo. Solo che lo dice un po’ meglio della mia traduzione. Il messaggio non dev’essergli entrato ancora in mente, comunque. Livia ha dei problemi, ha evidentemente dei problemi. È così evidente che se ne sono accorti persino Pasquino ieri sera e Ilaria del Carretto stamattina, Pietro Micca l’altro ieri e il cardinale Dusmet dopodomani. In qualunque piazza d’Europa, Mazzini è sempre troppo in paranoia per accorgersene, ma intanto i distributori di merendine di Orly, Barajas, Heathrow, Charleroi, Porta Garibaldi, Termini e Porta Nuova l’hanno intuito al volo.
Agganciato ai problemi di Livia, più peso morto di una ruota di scorta sul fondo di un bagagliaio, in un mese scarso sono dovuto salire su tre bus di sei ore, cinque aerei e otto treni, per un totale di sedici cieli diversi. Il fine ultimo di tutti questi ultimi spostamenti credo di averlo afferrato ieri per la prima volta. Come ogni mattina – e non c’è stato uno sgarro da quando sono entrato nella tasca del suo cappottino ripieno di piume d’oca –, Livia ha pestato la sveglia alle 5.45, è corsa in bagno a sciacquarsi il cavo orale e, senza interrompere la corsa, si è fiondata sulla tavola 20 dell’Atlante geografico De Agostini edizione 2005/2006 tracannando un succo d’arancia. Ha piantato una croce sulla destinazione di ieri e ha evidenziato in rosso la meta di oggi.
Il percorso che abbiamo disegnato sulla tavola 20 fino a questo momento è un camposanto minato di croci. E adesso posso dire con cognizione di causa che è un itinerario di distruzione. Livia non invaderà la Polonia, ma il suo piano è studiato strategicamente nel dettaglio: sterminare me e i miei compagni di viaggio, nel luogo esatto in cui ci ha associati definitivamente a qualcuno che oggi è un’assenza. È bene che precisi due cose. Uno: io ero un regalo. Due: dentro questo sacco di plastica spessa che profuma ancora di detersivi, non sono l’unico non-essere sigillato con triplo nodo.
Cominciamo da me, però, perché credo proprio che mi odi in un modo sufficiente a riservarmi la fine peggiore. E anche il vostro analista vi direbbe che non soffro di manie di persecuzione. I miei giorni all’aria aperta con Livia sono durati pochissimo. Guignol è diventato subito l’ultimo regalo del suo viaggio di nozze, ma anche del suo matrimonio. Insomma, so di morte, le ho portato una sfiga nera e così mi ha chiuso dopo nemmeno 24 ore nel sacco con l’etichetta «OGGETTI SOPRAVVISSUTI ALLE PERSONE».
Il suo matrimonio fallito, infatti, c’entra fino a un certo punto: a farmi compagnia in questa claustrofobia al profumo di candeggina, c’è un inventario anteriore al mio acquisto, e logicamente anche alla rottura con il marito. È redatto su un foglio A4 macchiato di caffè e comincia così:
labello fucsia della nonna, deceduta a Catania nel 2008 dopo un’agonia con le labbra fucsia (saltato fuori da un cassetto del comodino tre mesi dopo i funerali); mostarda di Digione scaduta nel 2015, comprata a Nantes con Julien per una cena mai più organizzata; Lettera al padre di Franz Kafka edizione Feltrinelli (ereditata da Francesco dopo che è morto, Roma, agosto 2012); borsetta di lino bianca, scagliata in faccia a Giovanni l’ultima sera a Milano; go-pro con filmati subacquei (unico ricordo bello di una vacanza in Sardegna da dimenticare); acquerelli dello zio, importati da Madrid l’anno che se n’è andato; scarpe da trekking, usate almeno un milione di volte per scalare il Monviso dandogli il braccio.
Il foglio è strappato in questo punto preciso, ma vi siete fatti un’idea del bel clima che si respira qui dentro. Devo ammettere che Livia è stata abilissima a creare questo sottovuoto. Dovreste vedere con quale cura isola il nostro sacco dentro altri sacchi prima di ficcarlo in valigia, ogni volta. Il suo terrore è che la nostra sporcizia fuoriesca da qualche sfiatatoio impercettibile e finisca per contaminare vestitini, mutande, libri, camicette, pigiami, beauty, lentine, profumi, pantaloni, calzini e insomma la metà autorizzata del suo bagaglio. Ai suoi occhi siamo appestati. Se qualcosa – una sciarpa un’agenda un reggiseno – dovesse entrare in contatto diretto con la superficie del sacco più vicina a noi, contrarrebbe automaticamente il nostro destino di condannata a morte. Alleggerirebbe il bagaglio o finirebbe a sua volta nel sacco.
Lione, 13 gennaio 2018
Oggi è l’ultimo giorno del viaggio. Dentro il sacco sono rimasto solo, per i miei compagni non c’è stato nulla da fare. Siamo partiti da una rosa essiccata a Bologna, e ieri siamo arrivati a una scatoletta infiocchettata a Berlino. Ho lottato nove mesi per rivendicare i diritti degli oggetti, per urlare la vita delle cose, che sopravvive ai congedi e ai cadaveri, resistente ai melodrammi delle perdite e agli spettacoli delle salme, indipendente. Mi sono dimenato dentro questo sacco più forte che ho potuto, ma Livia è implacabile. La tecnica di esecuzione era la stessa per tutti, e lo sarà anche per me fra qualche minuto: sul tavolo del boia troneggiano sei bottiglie disinfettanti potentissimi e, alla destra dei veleni, una spugna abrasiva. Livia mi afferrerà dal nasone come il primo giorno e mi ripulirà dalla sporcizia che ha ricevuto dal mondo con tutta la violenza che conosce. Sul mio tessuto epiteliale di plastica tossica non esisteranno più microbi e batteri, verrò corroso strato per strato, finché non sanguinerò. Potrà gongolare da sola nel gorgoglio di quei fiotti.
Ci siamo. Mi tira fuori dal sacco. La spugna è imbevuta di tutta la candeggina che riusciva a trattenere, adesso diventa un bavaglio, soffoco. Perché ti sei fermata, Livia? Improvvisamente l’ha scostato. Mi fissa con gli occhi sbarrati. Forse ha capito, forse mi lascia parlare.
Barbara Di Stefano